Industria manifatturiera, le incongruenze.
Da diverso tempo e comunque in ritardo rispetto gli Stati Uniti, in Italia e nelle UE si discute di industria manifatturiera. (Evviva) Quantificando il livello di “industria necessaria” in una democrazia avanzata, più o meno c’è un consenso unanime al 20% dei prodotti consumati nel mercato. Tradotto in parole più semplici, su 100 beni consumati/acquistati, almeno 20 dovrebbero essere prodotti localmente; attualmente siamo intorno al 15% in Italia e ancor meno in Europa (tra il 12 e il 15%). Su questo ragionamento, da anni, c’è una sorta di militanza da parte mia a favore dell’industria, anche se l’obiettivo del 20% non viene ritenuto adeguato per assorbire 3 milioni di disoccupati (ammesso che vogliano tutti lavorare nel settore secondario!). Fermo restando che già il 20% è ambizioso e difficilmente raggiungibile negli anni del progetto Tajani, valido anche in ambito Ue, un livello adeguato per garantire quel benessere che è stato già goduto nel periodo 2000-2008 dovrebbe essere pari al 45-48% dei beni consumati. Va anche sottolineato come la ricchezza vissuta e persa, sia il frutto di una sbagliata applicazione delle politiche commerciali di globalizzazione. In pratica la colpa del malessere, per dargli un nome, è globalizzazione. Una bella idea teorica mal concretizzata. Come l’euro. Chiarito il contesto di base sul quale ogni successivo ragionamento prende forma, ecco alcuni comportamenti imprenditoriali su cui riflettere:
a) un imprenditore padovano (120 dipendenti, azienda manifatturiera, 12 milioni di euro di fatturato di cui esportato al 70% scarso) posto di fronte alla scelta tra qualità e quantità, opta per quest’ultima. Nel dettaglio. Una squadra di lavoro composta da operai extracomunitari, viene integrata con un artigiano italiano in avanzata età, che ha dovuto chiudere l’attività. L’artigiano, impegnato in un lavoro molto duro e pesante, non riceve assistenza e coordinazione dalla squadra di lavoro, che gelosamente trattiene ogni nozione tecnica. Nonostante ciò, l’artigiano italiano partecipa ugualmente al lavoro con ritmi più lenti, ma con una qualità superiore. Gli altri invece puntano sulla velocità e la quantità, provocando una quantità di scarti di lavorazione molto alta e lasciando comunque procedere in produzione pezzi difettosi, “di cui non ce ne si accorge”. All’imprenditore viene spiegata l’intera vicenda. La conclusione? Essendo l’artigiano con una resa inferiore del 30% rispetto agli altri, non gli viene rinnovato il contratto perdendo il lavoro;
b) dal reparto magazzino chiama in direzione il Capo Reparto informando che gli operai hanno freddo. Da una rapida verifica emerge che l’impianto di riscaldamento è funzionante ma spento. L’imprenditore risponde: con il freddo si lavora meglio e poi non ne sento il bisogno. Approfondendo, emerge che l’intera catena di produzione è afflitta da un tasso d’assenza per permessi-malattia pari al 10% della forza lavoro, abbattendo drammaticamente, in questo modo, la produttività. Chissà perché!
Concludendo. Al di là dei problemi di globalizzazione, l’industria italiana può restare sul mercato solo in forza all’alta qualità del suo prodotto. Considerare la quantità a discapito degli standard di produzione è un atteggiamento suicida. Poco conta che il cliente non se ne accorga; presto capirà e non rinnoverà gli ordini d’acquisto. Per quanto riguarda il risparmio va ricordato che è un’arte, anzi un’architettura con regole e contrappesi molto precisi. E’ facile illudersi d’aver ottenuto un risultato, quando poi si resta esposti su un altro lato.
Buon lavoro.



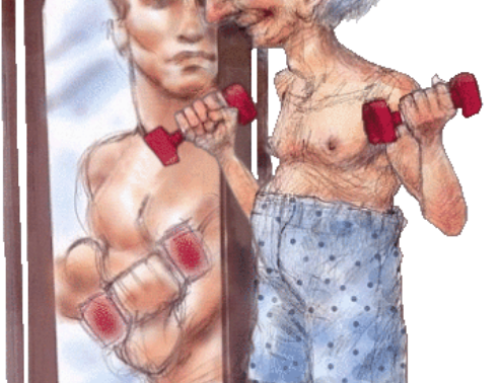
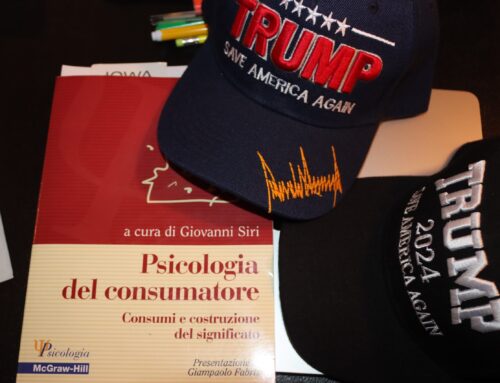

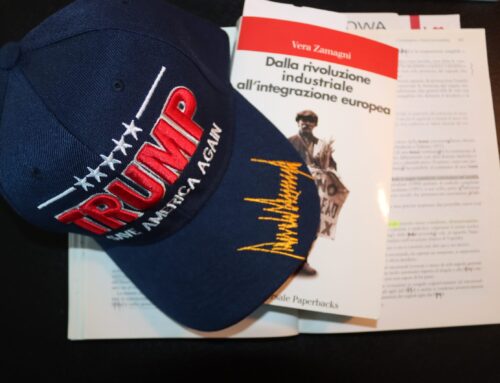
Scrivi un commento