Il prigioniero da Parkinson: quando entra in simbiosi con la sua stessa malattia?
Questi studi rientrano nell’assetto più ampio di dottrina della sociologia del dolore (pain sociology) quindi della Teoria del Prigioniero da Parkinson (The Prisoner or Parkinson)
Il Parkinson è una brutta malattia, ma lo sono anche l’Alzheimer, il cancro, la leucemia etc. perchè tutte trasformano il malato in un corpo ospite per condurlo a morte. Il brutto di queste patologie, non consiste nella loro esistenza e lunghezza (fine vita) nel corso degli anni, ma nel riuscire a trasformare il paziente in uno schiavo per l’integrale residuo vita.
Mentre la cura, in termini chimici, a queste malattie, è di pertinenza della medicina, ad altra scienza compete il riscatto del malato, ovvero quella capacità di reazione che sola è in grado di consegnare la titolarità di “essere umano”. E’ ancora un essere umano colui che reagisce. E’ invece ormai uno schiavo, spesso una larva umana, quella persona che ha abdicato al male lasciandosene divorare. In pratica il paziente diventa cibo per la malattia se non reagisce. Per quanto crudo e spietata sia questa disamina (c’è una oggettiva reticenza nel dirlo in chiaro ai malati che vengono così lasciati – abbandonati – in una terra di nessuno) la vera domanda è un altra: è possibile reagire?
Prima di tutto, e specificatamente sul Parkinson, nella cui area sono stati svolti questi studi, (Teoria del Prigioniero da Parkinson – The Prisoner of Parkinson) va fatta un’importante distinzione:
- è malato o paziente colui che soggiace alla malattia riducendosi a diventarne “cibo”;
- è considerato un prigioniero che evade, quel malato che reagisce per confermare la sua dignità d’essere umano contro la malattia. Per farlo ricorre a ogni tipo di “appiglio” possibile sia questo culturale, relazionale, intellettuale, emotivo e sentimentale. Il prigioniero da Parkinson è un personaggio che impone alla malattia la sua specificità di carattere. Come ampiamente descritto precedentemente, in altri studi sul Parkinson, (vedi studi precedenti già pubblicati in ambito di sociologia del dolore – pain sociology e il prigioniero da Parkinson) questa reazione nasce dal singolo ex paziente, oggi evoluto a prigioniero, ma va aiutata sia in ambito reale che virtuale attraverso la frequentazione di comunità, scrivendo, dipingendo, passeggiando, fotografando, pensando, amando meglio e di più il partner, educandolo a non vergognarsi del coniuge ammalato, a riaprire una sessualità comunicativa di coppia che non si limiti al mero atto fisico. In questa contro offensiva del prigioniero, secondo la teoria del Prigioniero da Parkinson – The Prisoner of Parkinson, si ristabilisce quell’equilibrio perduto tra l’essere una larva (cibo) per la malattia e il reagire con dignità e fierezza. Il Parkinson è stato abbattuto in questo modo? Sotto il punto di vista chimico e medico no, in termini di relazione umana e di dignità SI. Ecco a cosa serve la sociologia nel Parkinson attraverso le sue nuove teorie.
Chiariti questi passaggi, del resto già noti nella dottrina, ora il punto più importante è capire quando la malattia corrompe la capacità di resistenza del malato se questi non evolve in Prigioniero. Ebbene si conferma sempre di più come 6 mesi siano sufficienti per l’involuzione e la trasformazione del corpo di un paziente in ambiente di ospitalità in una forma di convivenza e complicità.
Giunti a questo stadio d’interazione malattia-paziente, quindi successivo al primo semestre di contatto-convivenza con la malattia (di fatto contagiati) è certamente possibile tornare indietro, ma a costi umani sempre più sostenti al passare del tempo.
Qui si spiega l’eccesso d’ostilità che l’ambiente del Parkinson italiano ha riservato a questo tipo di riflessioni, ostacolandone in chiaro il semplice confronto. Come mai e perchè accade che chi dovrebbe beneficiare della ricerca, si schieri così apertamente e senza riflessione, quasi fosse una scheggia, contro le nuove prospettive a suo favore? E’ un mistero!
In realtà l’attuale generazione di malati (non quelli che sono invece evoluti a prigionieri – troppo pochi) cercano solo d’essere compatiti condannandosi da soli. Esaminando questi sterili scatti da parte dei malati che inutilmente invocano il rispetto, senza guadagnarselo nella lotta per l’esistenza dignitosa, si osserva un anomalo atteggiamento bastato sulla mentalità dell’assuefazione rispetto quella del riscatto. L’aver esclusivamente delegato alla medicina la lotta contro la malattia è una responsabilità che il Parkinson italiano si assume e anche quello d’aver pensato a una sociologia riduttiva e limitata alla conta dei pazienti in Italia e al suo livello di cura medica. La responsabilità non è solo dei sociologi, che hanno partecipato a una visone ridotta della dottrina sociologica, ma dello stesso Parkinson italiano che non ha vigilato, indirizzato, capito, consigliato.
Al netto delle riflessioni sulle mancate opportunità che non sono state colte dal Parkinson italiano, resta il problema di fondo: dopo 6 mesi dalla diagnosi, la capacità di restare umani, in un malato di Parkinson è sostanzialmente corrotta, entrando in una assuefazione-convivenza con il male. Va riconosciuto però come il concetto di recupero (la trasformazione da malato a prigioniero) NON è mai da considerarsi impossibile! Infatti anche il malato da Parkinson, affetto da decine di anni è in grado di riscattarsi, certamente con un impegno maggiore rispetto gli altri, ma è in grado di farcela. Questo è sensazionale! Significa che la ribellione al male cova “sotto le ceneri” della sofferenza; il pur essere diventati “larva per la malattia” NON esclude la riabilitazione allo stadio di prigioniero. Ovviamente questo riscatto richiede aiuto, amore, pazienza, ascolto, in pratica richiede una procedura che è quella tipica della sociologia del dolore, inserita nella Teoria del Prigioniero.
Gli strumenti ci sono e vanno affinati, perfezionati, condivisi e sperimentati ancora e ancora. Basta usarli per conquistare uno stadio d’umanità nel dolore.
Una meravigliosa esperienza in questo senso è stata osservata nel “paziente zero” che, nonostante sia afflitta dal Parkinson da oltre 35 anni ha caparbiamente deciso di cambiare vita. Un dramma, una vittoria.


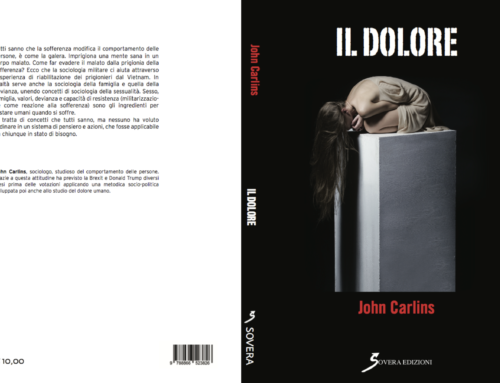




Scrivi un commento